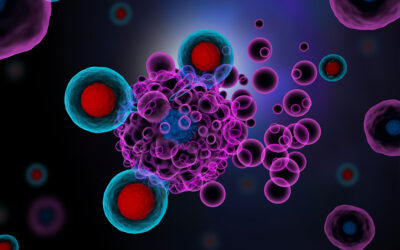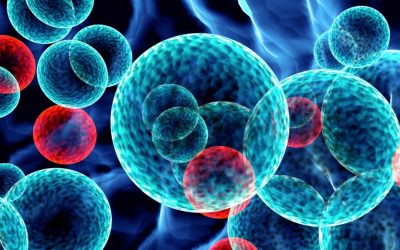LE NEOPLASIE MIELODISPLASTICHE – SMD-
Le neoplasie, o sindromi mielodisplastiche (SMD) sono un gruppo di tumori del sangue caratterizzate da
alterata crescita della cellula staminale mieloide. Le cellule staminali non sono più in grado di completare il loro processo maturativo in modo corretto e quindi si instaurano stati di anemia (bassi valori di
emoglobina e globuli rossi), piastrinopenia (bassi valori di piastrine) e leucopenia (bassi valori di globuli bianchi) di gravità variabile. Esistono differenti tipi di neoplasie mielodisplastiche sulla base delle
caratteristiche cellulari e delle alterazioni genetiche delle cellule malate. Una terapia pregressa con farmaci chemioterapici o radioterapia aumenta il rischio di sviluppare questo tipo di malattie.
INCIDENZA
Le neoplasie mielodisplastiche hanno un’incidenza stimata che si aggira sui 2-10 casi l’anno per 100.000 persone. Sono tipiche dell’età avanzata, rare prima dei 50 anni. L’età media alla diagnosi si aggira sui 70 anni.
CAUSE E FATTORI DI RISCHIO
Ad oggi sono noti alcuni fattori di rischio in grado di aumentare le possibilità di sviluppare questa
patologia:
– età avanzata
– il sesso maschile
– esposizione a determinate sostanze chimiche compresi tabacco, pesticidi, fertilizzanti e solventi come il benzene, metalli pesanti come mercurio o piombo
– trattamento pregresso con chemioterapia o radioterapia
Nonostante queste indicazioni non è però ancora possibile definire con certezza quale sia la causa della malattia, che sembra essere conseguenza di un progressivo accumulo di mutazioni e alterazioni
genetiche dovute all’ esposizione agli agenti sopra menzionati. L’acquisizione di mutazioni genetiche determina la formazione di un clone neoplastico in cui le cellule del midollo non saranno più in grado di maturare in modo corretto. In una porzione rilevante di casi (30-40%) la malattia evolverà ulteriormente e si trasformerà in una Leucemia Mieloide Acuta.
SINTOMI E SEGNI
I sintomi riferiti sono spesso la conseguenza della ridotta produzione delle cellule del sangue, in
particolare i pazienti possono riferire:
– stanchezza progressiva
– sensazione di fiato corto anche per sforzi lievi
– febbre e infezioni ricorrenti
– sanguinamento gengivale o epistassi ricorrenti, petecchie o ematomi agli arti superiori e inferiori
DIAGNOSI E CLASSIFICAZIONE
Per formulare una corretta diagnosi sono richiesti i seguenti esami:
- Esami del sangue: in particolare emocromo (spesso si osserverà la riduzione dei valori di emoglobina, globuli bianchi e/o piastrine). Si richiedono spesso ulteriori esami per escludere altre patologie, in particolare stati carenziali o situazioni acute o croniche infiammatorie o infettive (dosaggio vit. B12, folati, stato del ferro, dosaggio eritropoietina, PCR, TSH, indici di emolisi, dosaggio autoanticorpi)
- Valutazione osteomidollare: aspirato midollare con analisi morfologica, immunofenotipica, citogenetica e FISH, molecolare e biopsia osteomidollare.Eventuali ulteriori analisi su midollo vengono richiesti in caso di studi clinici controllati Le neoplasie mielodisplastiche vengono classificate in base a caratteristiche genetiche e morfologiche
PROGNOSI E DECORSO
La prognosi della malattia dipende da alcuni fattori correlati al paziente (età, condizioni generali e comorbidità) e altri correlati alla malattia. I principali fattori correlati alla malattia che definiscono gli score prognostici più utilizzati (IPSS, WPSS, IPSS-R) sono: numero di citopenie su sangue periferico, numero di blasti nel midollo, analisi citogenetica, fibrosi midollare. Negli ultimi anni, lo sviluppo di tecnologie innovative come la Next Generation Sequencing (NGS) ha permesso di caratterizzare in modo più approfondito dal punto di vista genetico queste patologie.
In generale, il decorso può essere distinto in quattro gruppi: cronico protratto
– la malattia rimane stabile per lungo tempo, senza segni di peggioramento o evoluzione dei sintomi; cronico progressivo – l’andamento è comunque orientato alla lunga durata, ma con un lento peggioramento della sintomatologia e dello stato clinico della malattia;
subacuto – caratterizzato da un progressivo peggioramento della malattia in un arco di tempo relativamente breve, con una frequente evoluzione in leucemia mieloide acuta (LMA);
acuto – la malattia peggiora rapidamente, la trasformazione in leucemia
mieloide acuta (LMA) è praticamente certa ed avviene in tempi brevi.
TERAPIA
La terapia impostata dipende dal grado di severità della malattia, dagli indici prognostici, dall’età e dalle condizioni cliniche del paziente. Per alcuni pazienti è sufficiente solo un monitoraggio clinico poiché le alterazioni dell’emocromo sono lievi. Le terapie disponibili sono:
– Terapia trasfusionale: trasfusioni di globuli rossi o piastrine
– Terapia ferrochelante: per ridurre il sovraccarico di ferro nei pazienti che vengono sopposti a numerose trasfusioni di sangue,
– Agenti in grado di stimolare la produzione di globuli rossi: nei pazienti con anemia e malattia a rischio basso o intermedio-basso spesso viene proposta la terapia con eritropoietina con somministrazione mono o bisettimanale per stimolare il midollo a produrre più globuli rossi.
Di recente approvazione è l’utilizzo di luspatercept (capostipite della classe degli agenti di maturazione eritroide) per il trattamento di pazienti adulti con un particolare tipo di MDS a rischio
basso o basso-intermedio caratterizzato dalla presenza nel midollo osseo di cellule particolari chiamate “sideroblasti ad anello” e anemia trasfusione dipendente con risposta insoddisfacente o non idonei a terapia basata su eritropoietina. A breve questo trattamento potrebbe essere esteso
anche in quei casi in cui non vi è la presenza dei sideroblasti ad anello e in fasi più precoci della malattia.
– Terapia con farmaci biologici specifici: lenalidomide, farmaco immunomodulante utilizzato in particolare nelle SMD a rischio basso o basso-intermedio con delezione 5q che presentano anemia; agenti demetilanti (azacitidina) utilizzati nelle forme SMD ad alto rischio in grado di reindirizzare le cellule verso il loro normale sviluppo.
– Terapia immunosoppressiva: riservata a pazienti con caratteristiche midollari specifiche.
– Chemioterapia seguita da trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche: unica vera terapia curativa, questa terapia, molto simile a quella utilizzata nella leucemia mieloide acuta,
viene riservata a pazienti giovani in buone condizioni cliniche affetti da SMD ad alto rischio di evoluzione in leucemia.
In considerazione delle recenti scoperte in questo tipo di tumori, l’arruolamento in un trial clinico è una strategia terapeutica consigliata.
Infatti, l’utilizzo di nuovi farmaci è spesso limitato solo a pazienti arruolati in determinati studi clinici in quanto molte di queste medicine non sono ancora garantite dal nostro sistema sanitario nazionale.
Dott.ssa Stefania Agnoli
UOC Ematologia, Ospedale di Legnano, ASST Ovest Milanese
Gli ultimi aggiornamenti scientifici:
Un futuro oltre la malattia: affrontare la cronicità nelle leucemie e nel mieloma
Settembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sui tumori del sangue e AIL ha deciso di creare delle campagne informative e di servizio per i pazienti e i loro familiari. Per quest'anno lanciamo il progetto "Un futuro oltre la malattia: affrontare la cronicità...
Trapianto di midollo e terapia genica, due tappe che hanno segnato la storia della medicina
Riportiamo l'articolo di Alessandro Malpelo apparso su Quotidiano Nazionale il 22 novembre 2020 - disponibile qui "Ogni anno, in Italia, vengono diagnosticati più di 33mila nuovi casi di tumore del sangue. Tra i più frequenti figurano i linfomi, le leucemie e il...
CAR-T e linfoma: i dati sono incoraggianti
L’immunoterapia sta rapidamente cambiando la storia clinica di pazienti che non avrebbero più avuto opzioni terapeutiche. In alcuni casi è possibile che raggiungano la guarigione con l’utilizzo di terapie innovative come le cellule CAR-T. Due recenti pubblicazioni...
Nuovi dati clinici sulle terapie CAR-T
Un nuovo studio dell’Istituto Nazionale dei Tumori, reso possibile anche grazie al contributo di AIL Milano, dimostra le potenzialità delle terapie a base di cellule CAR-T per i malati onco-ematologici.
Come verranno decisi i centri per l’erogazione delle CAR-T?
Sebbene i farmaci siano disponibili, la macchina organizzativa per la somministrazione delle terapie a base di linfociti ingegnerizzati è ancora in alto mare. Gli esperti, riuniti a convegno, immaginano un modello efficiente e capace di garantire equità di accesso sul...
Mieloma multiplo, nuove speranze dalla terapia con CAR-T
Pazienti pluritrattati rispondono alla terapia CAR-T, in alcuni casi in modo completo. Sono i risultati degli studi presentati al congresso di ematologia negli Usa. I dati su efficacia e sicurezza per questa malattia, però, non sono ancora definitivi “Risultati...